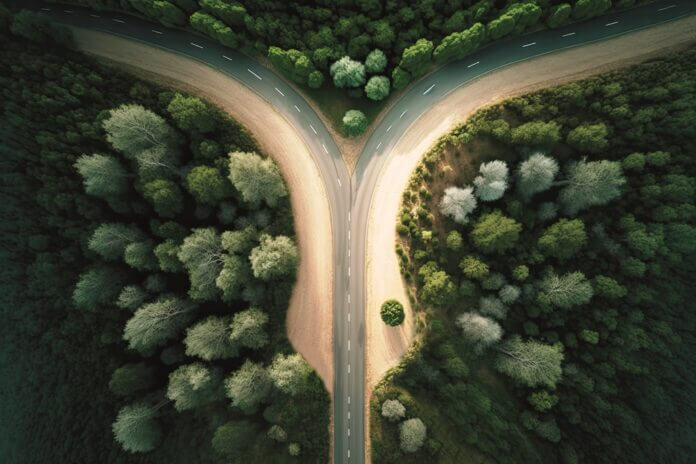Theodore Levitt, economista tedesco e professore alla Harvard Business School, è famoso per aver divulgato nel mondo economico il termine “globalizzazione dei mercati”.
È meno famoso per aver inventato un concetto diventato di primaria importanza nell’economia. È la teoria del “Job To Be Done”, e cioè la necessità, per un imprenditore, di comprendere il fine ultimo che vuole perseguire il suo cliente, a prescindere dal mezzo con cui ottenerlo. Solo comprendendolo, potrà evitare di trovarsi “fuori mercato” con i suoi prodotti, di punto in bianco e senza un apparente perché. Come tutte le idee geniali, una volta espressa può apparire addirittura banale, ma la storia ci ha insegnato la fine che hanno fatto grandissime realtà industriali che hanno perso di vista l’obbiettivo ultimo, innamorandosi solo del mezzo con cui raggiungerlo (Blockbuster e Blackberry, ad esempio). E allora, visto dalla prospettiva di un servicer o di un istituto specializzato, qual è il job to be done di una banca relativamente al credito deteriorato? Averne il meno possibile e, per la quota che fisiologicamente si crea, ridurne la massa nel minor tempo possibile e al minor costo possibile.
Trent’anni fa, l’approccio al credito deteriorato da parte degli istituti bancari era molto “tradizionale”. Complice il fatto che i ricavi dell’attività bancaria erano mediamente molto alti e i volumi di ammaloramento più contenuti (anche per regole meno vincolanti), le banche avevano i loro uffici interni che erano la gioia degli Studi Legali convenzionati a cui davano a ripetizione incarichi per il recupero giudiziale. Le percentuali di recupero e i relativi costi non erano un grosso problema o quanto meno non erano sentiti come tali. Solo alla fine degli anni ’90 del secolo scorso, due banche sistemiche affrontarono la questione con una visione più “industrializzata”: Intesa, con la sua bad bank “IGC” e Unicredit, con il suo servicer “UCCMB”. Ho volutamente utilizzato termini diversi per inquadrare queste due esperienze perché diverso era l’approccio: IGC comprava i crediti dalle banche del Gruppo e poi li gestiva autonomamente, mentre UCCMB era (almeno inizialmente) il gestore di Gruppo dei crediti deteriorati, che restavano sui libri delle banche. Ciascuna, a modo suo, rappresentava un modello di come si sarebbe sviluppato il mercato. Era l’alba di una nuova era, favorita anche dalla promulgazione della L. 130/99 sulle cartolarizzazioni.
Gli anni 2000 hanno visto arrivare i primi investitori stranieri, sottoscrittori delle note delle prime grandi operazioni di cartolarizzazione di crediti deteriorati, e con essi la necessità dello sviluppo di un mercato di servicing indipendente (nel 2005, IGC viene ceduta a Fortress, che la incorpora in Italfondiario). Si sviluppano modelli di calcolo dei flussi di incasso, dei costi ongoing, con scenari conservativi e aggressivi, dove la differenza la faceva chi effettivamente recuperava il credito. Il monitoraggio costante delle performance di queste cartolarizzazioni e il continuo tentativo di migliorare i flussi di cassa, ha portato alla nascita di figure specializzate e professionalità dedicate a questo mestiere.
L’arrivo della grande crisi del 2008-2012, provocata anche dalle cartolarizzazioni di mutui subprime, paradossalmente è stata in gran parte risolta utilizzando il medesimo strumento che l’aveva provocata: le cartolarizzazioni. E il picco di crediti deteriorati del 2015 si è trasferito, anche abbastanza velocemente, dalle banche agli SPV e ai loro servicer.
Ma se le banche avevano trovato un altro modo per raggiungere il loro job to be done per i crediti deteriorati, passando da una gestione interna e “artigianale” ad una gestione esterna tramite le cessioni e/o accordi di servicing in attesa della successiva cessione, il metodo di recupero del credito in realtà non era cambiato molto. Erano cambiati i titolari, ma tutto ciò che non veniva recuperato con accordi stragiudiziali, spesso subiti per insistenza del debitore, veniva (e viene) in assoluta prevalenza gestito giudizialmente. È una via che in questi anni ha manifestato tutti i suoi limiti: dal 2014 al 2022 i tempi medi delle esecuzioni immobiliari a livello nazionale sono progressivamente aumentati, nonostante l’introduzione di riforme che avrebbero, invece, dovuto ridurli. E il trend in aumento non può essere giustificato dal periodo COVID, perché si era già manifestato nel periodo 2014-2019. Se a ciò si aggiungono, in ordine di apparizione, le eccezioni cicliche sui tassi usurari, sulla nullità parziale delle clausole fideiussorie, sulla presunta concessione abusiva del credito, l’obbligatorietà della preventiva mediazione civile, l’introduzione delle misure protettive nella composizione negoziata della crisi, fino a giungere alla recentissima messa in discussione del giudicato civile per la tutela postuma del debitore consumatore, si può ben comprendere come l’approccio giudiziale al recupero del credito risulti oggi perdente sia sotto il profilo dei tempi che sotto quello dei costi.
Il 2023 potrebbe essere un anno di svolta nel mondo del credito deteriorato, e per comprenderne meglio i motivi conviene ripartire dall’inizio
Qual è il job to be done di una banca, relativamente al credito deteriorato? Averne il meno possibile e, per la quota che fisiologicamente si crea, ridurne la massa nel minor tempo possibile e al minor costo possibile. Per ridurre le classificazioni dei crediti, le banche si sono dotate di strumenti di monitoraggio sempre più raffinati, e lo sviluppo di questo settore è continuo, con risultati sempre più accurati e precisi.
La riduzione delle masse di crediti già classificati, invece, deve rispondere a due obiettivi precisi: tempi e costi.
Affrontando brevemente i principali strumenti oggi disponibili, vediamo che:
- l’approccio “classico” di gestione del recupero tramite azioni che facciano leva anche e principalmente sull’attività giudiziale è oggi inadeguato sia per i tempi che per i costi. E ciò vale sia per le strutture interne alle banche sia per i servicer che gestiscono su mandato;
- la recente impennata del costo del denaro potrebbe mettere sempre di più in crisi il mercato delle cessioni e/o cartolarizzazioni, i cui business model ora devono garantire rendimenti così elevati e in tempi di recupero così dilatati da esprimere prezzi che sviliscono il controvalore ceduto e stimolano le banche a valutazioni sulla effettiva convenienza di una tale perdita di valore.
Inoltre, il progressivo deterioramento di una quota di finanziamenti c.d. COVID, garantiti dallo Stato tramite MCC e SACE, sta parzialmente cambiando la composizione dei portafogli di NPE, sempre più legati alla necessità di una preventiva escussione della garanzia ad opera della banca e quindi non immediatamente cedibili, mentre il protrarsi degli effetti negativi della guerra Russia-Ucraina, sommati ad un’inflazione particolarmente elevata e all’attuale costo del denaro, stanno effettivamente producendo un aumento del deterioramento del credito bancario, che, se prolungato nel tempo, non potrà che incidere negativamente sull’NPL Ratio delle banche.
Quindi, se da una parte il problema della gestione del credito deteriorato bancario è ben lungi dall’essere risolto, dall’altra, i principali strumenti a disposizione stanno manifestando la loro inefficienza.
Chi si offre oggi alle banche (investitori e piattaforme di servicing, spesso legati tra loro) per risolvere il problema, dovrà quindi evitare l’errore di Blockbuster: il fine ultimo non può e non deve essere perseguito con mezzi ritenuti ormai insoddisfacenti dal cliente (banca).
Il recente mercato degli UTP, sviluppatosi in prevalenza mediante l’utilizzo di Fondi di Investimento Alternativi, a mio parere può essere visto come un primo approccio innovativo: gli investitori restano le banche (mediante la sottoscrizione delle quote del Fondo) e i gestori hanno come obiettivo primario non quello di liquidare le garanzie di un credito, bensì quello di farlo fruttare, magari attraverso il rilancio di un’attività commerciale o industriale, oppure attraverso la rimodulazione del pagamento rateale del debitore, in base alle proprie disponibilità (reperforming).
È solo un esempio, con tutti i limiti che comporta e che dovranno essere affrontati per sviluppare questo mercato, ma potrebbe essere una base di partenza per rivedere completamente l’approccio al recupero del credito.
Anche in questo caso occorrono specifiche professionalità all’interno dei servicer e un approccio prudente e serio ai piani di rilancio, i quali, a loro volta, devono garantire rendimenti adeguati. Dal lato delle banche, per far sì che tale approccio abbia un senso, occorrerà anticipare il più possibile l’individuazione delle difficoltà finanziarie dei clienti onde evitare di arrivare troppo tardi. Così si potrebbe addirittura immaginare un contenimento ulteriore delle classificazioni, intervenendo in accordo con il cliente e al momento giusto.
Se proposte innovative non arriveranno da investitori e servicer, probabilmente le banche dovranno attrezzarsi in autonomia, ma in tal caso, tutti potrebbero aver perso un’occasione.